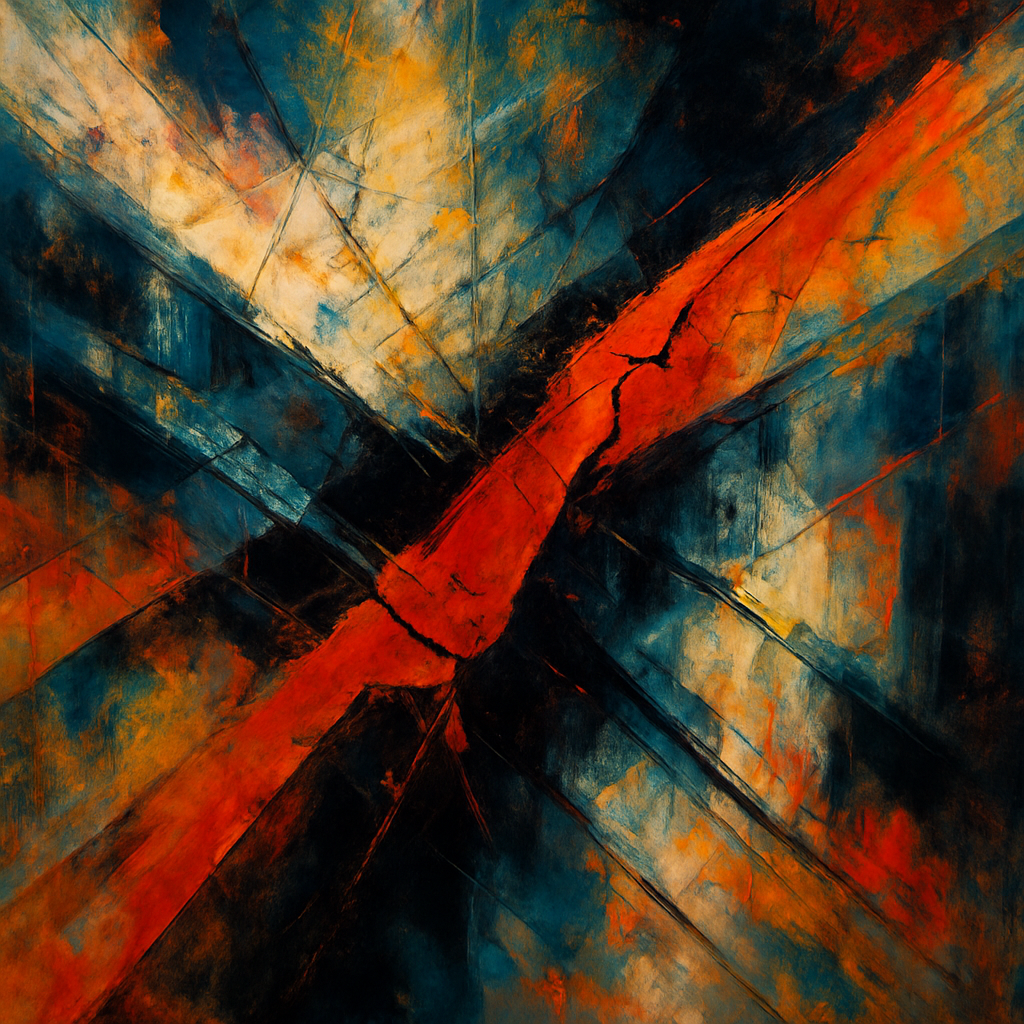
Perché l’Intelligenza Artificiale rappresenta la fine del capitalismo? · Parte III: La fine come rottura
Nessun sistema umano è mai terminato nel silenzio. Né gli imperi, né le religioni egemoniche, né i modelli economici che sembravano incrollabili si sono dissolti in modo graduale e ordinato. I sistemi umani non finiscono: si spezzano. Resistono finché riescono a convincere la maggioranza che la loro esistenza sia naturale, necessaria o almeno tollerabile; ma quando questo sostegno si dissolve, quando la legittimità evapora, la fine non assume la forma di un’estinzione progressiva, ma di una frattura. A volte questa rottura è fisica, sotto forma di guerra o rivoluzione; altre volte è istituzionale, simbolica o psicologica, un crollo meno visibile ma altrettanto devastante, in cui ciò che sembrava stabile si sgretola all’improvviso.
La storia è piena di questi scoppi. L’Impero Romano non si è ritirato dalla scena per lasciare spazio a un’altra era: è collassato tra guerre interne, penuria, corruzione e una perdita irreversibile di fiducia nella promessa imperiale. Le monarchie assolute europee non hanno ceduto il passo alla democrazia per un atto etico, ma perché l’Antico Regime ha smesso di offrire qualsiasi giustificazione minimamente credibile per continuare ad esistere. La Riforma protestante non è stata una transizione dottrinale ordinata, ma uno scisma esploso quando la Chiesa non ha più potuto mantenere la coerenza tra il suo discorso spirituale e la pratica istituzionale. Anche l’URSS, uno dei progetti politici più rigidamente organizzati del XX secolo, non è scomparsa per una sconfitta militare: si è spezzata quando ha esaurito la sua legittimità ideologica e produttiva e la popolazione ha smesso di credere nel racconto che dava senso a decenni di sacrificio.
La costante storica è chiara. Le società possono tollerare per generazioni condizioni che, viste retrospettivamente, risultano insopportabili: fame, disuguaglianza estrema, repressione, sfruttamento sistematico. Ma nessuna struttura sopravvive quando la maggioranza smette di concedere consenso, anche se questo consenso è passivo, rassegnato o silenzioso. Perché ogni sistema umano, per quanto concentrato in un’élite — re, sacerdoti, burocrati, tecnocrati o magnati — dipende sempre, in un modo o nell’altro, da una legittimazione sociale ampia. Questa legittimazione può assumere molte forme: paura, fede, prosperità, abitudine, rassegnazione. Ma quando scompare, anche i sistemi che sembravano eterni crollano. L’aristocrazia francese ha vissuto secoli convinta del suo diritto naturale ad esistere fino a quando la combinazione di fame, crisi fiscale e umiliazione quotidiana ha reso impossibile mantenere la finzione. Lo stesso accadde agli imperi coloniali dopo la Seconda Guerra Mondiale o alle dittature latinoamericane che si sono mantenute finché la popolazione ha accettato, per disperazione o paura, la loro autorità. Quando un sistema perde la capacità di persuadere, intimidire o ispirare la maggioranza, non si riforma: si spezza.
Per capire perché il capitalismo contemporaneo si avvicina a questo tipo di rottura, è necessario tornare alla Guerra Fredda, il suo periodo di massima legittimazione storica. Durante quella fase, il capitalismo fu costretto a mostrare il suo volto migliore, non per altruismo, ma per rivalità geopolitica. Di fronte al comunismo sovietico — capace di articolare una narrazione alternativa e una promessa redistributiva — il capitalismo implementò politiche che oggi appaiono eccezionali: ampi sistemi di welfare, diritti dei lavoratori solidi, sindacati con reale potere negoziale, accesso diffuso a istruzione, sanità e alloggio. Tra gli anni Cinquanta e Settanta, in gran parte dell’Occidente, i livelli di redistribuzione toccarono vette storiche: aliquote marginali sulle grandi fortune superiori al 70 %, crescita salariale parallela all’aumento della produttività e una riduzione costante della disuguaglianza. Non fu una trasformazione morale del sistema, ma una parentesi funzionale: una sospensione temporanea della sua logica per mantenere la legittimità.
Quella parentesi terminò appena scomparve l’antagonista. La caduta del Muro di Berlino non segnò solo la fine del socialismo reale; liberò il capitalismo da ogni obbligo di contenimento. L’accumulazione, la deregolamentazione e la massimizzazione del profitto tornarono al centro. Il neoliberismo non fu una deviazione ideologica, ma il ritorno del capitalismo alla sua direzione originaria.
In questo nuovo scenario, il sistema dimostrò qualcosa di decisivo per comprendere la crisi attuale: può funzionare anche escludendo una parte enorme dell’umanità. Per quattro decenni, il capitalismo non ha escluso il 50 % più povero del pianeta; lo ha sfruttato in condizioni di precarietà lavorativa estrema, salari di sussistenza e vite ridotte alla mera sopravvivenza. Non ha garantito una qualità minima della vita, né diritti di base stabili, né sicurezza materiale. Ha utilizzato quella metà della popolazione quando serviva — nelle fabbriche, nei campi, nelle costruzioni o nei servizi — e l’ha scartata quando non era più redditizia. Eppure il sistema non è collassato: si è espanso, si è sofisticato, si è globalizzato e ha concentrato ricchezza come mai prima.
Ciò è stato possibile perché conservava ancora la sua base di legittimazione. Il capitalismo ha continuato a funzionare perché ha mantenuto all’interno del patto circa l’altra metà della popolazione: un’élite ridotta e un’ampia classe media globale. Non perché questa classe media fosse moralmente superiore, ma perché era funzionale.
Questo fragile equilibrio della classe media globale — circa il 40 % della popolazione mondiale — inizia a rompersi quando l’automazione cognitiva, resa possibile dallo sviluppo dell’IA, minaccia proprio il gruppo che ancora legittimava il sistema. Per decenni il capitalismo si è basato sul patto del lavoro: un impiego stabile, carriera ascendente, impegno ricompensato, identità costruita attorno al merito. Quel patto è stato la spina dorsale della classe media. Ma quando l’IA rende obsoleti non solo i lavori manuali, ma anche quelli amministrativi, tecnici, creativi e professionali, quel contratto simbolico si disintegra. Proseguire su questa strada non significa più escludere metà della popolazione, ma spingere il sistema verso uno scenario in cui fino al 90 % dell’umanità può restare strutturalmente relegata.
Per quarant’anni, il capitalismo ha deliberatamente trascurato il 50 % più povero della popolazione senza nemmeno garantire condizioni di vita minime. Allo stesso tempo, ha confuso la classe media globale attraverso un bipartitismo che, dietro promesse ricorrenti di ascesa sociale e stabilità, ha sistematicamente portato a più pressione fiscale sui redditi, indebitamento strutturale a vita e politiche redistributive che mai hanno toccato le grandi fortune. Il merito è stato usato come strumento di domesticazione e l’indebitamento come forma di controllo. Dare il minimo per estrarre il massimo è stata la formula che ha permesso al sistema di reggersi escludendo uno su due esseri umani. La domanda ormai non è più se potrà continuare a farlo, ma perché crede di poterlo fare.
E ci sono motivi per crederlo.
Il primo è storico e antropologico. Le élite non hanno mai saputo fermarsi. Re convinti del loro diritto divino, imperatori ossessionati dall’eternità, aristocratici aggrappati a privilegi irrazionali, magnati che concepiscono la ricchezza come segno di predestinazione. L’élite capitalista globale non è diversa. Agisce come se la sua posizione fosse naturale, permanente e indiscutibile, anche quando il sistema da cui dipende mostra chiari segni di esaurimento.
La seconda ragione è strutturale. La finanziarizzazione ha spezzato il legame tra popolazione e ricchezza. L’economia ormai non dipende più direttamente dal lavoro né dal consumo della maggioranza. La ricchezza si riproduce in circuiti autonomi — debito, derivati, speculazione e fondi d’investimento — che permettono al capitale di crescere indipendentemente dalla vita materiale della popolazione. Questa finzione di autosufficienza poggia su una regola fondamentale: il gioco è truccato dall’inizio, perché l’1 % della popolazione controlla circa il 50 % degli attivi finanziari. Il banco vince sempre.
La terza ragione è matematica. Fuori dall’élite resta ormai solo circa il 25 % della ricchezza mondiale da assorbire. Casa, istruzione, salute, risparmi e pensioni sono gli ultimi territori d’estrazione. Da dentro il sistema, resta poco da catturare, ma abbastanza per poter avanzare ancora, rafforzati dall’esperienza di quattro decenni in cui è stato possibile lasciare fuori metà dell’umanità senza conseguenze immediate.
Queste dinamiche convergono in un errore fatale: il capitalismo crede di poter continuare senza la maggioranza perché ha imparato a farne a meno. Ma questa illusione si scontra con la meccanica storica di tutti i sistemi umani. Nessuna struttura sopravvive quando la distanza tra élite e popolazione diventa illimitata, quando la legittimità evapora e la vita quotidiana si trasforma in un’esperienza costante di precarietà.
Tuttavia, il capitalismo contemporaneo introduce una novità inquietante. Mai prima un sistema aveva potuto contare su un apparato così sofisticato di gestione del malessere, dissuasione, sorveglianza, intrattenimento e produzione simbolica. L’erosione di legittimità che in passato sfociava in rotture visibili oggi può dissolversi in società atomizzate, depoliticizzate, dove l’esaurimento non sempre si traduce in azione collettiva. Attraverso un apparato di comunicazione globale senza precedenti, concentrato in pochissimi soggetti, con accesso illimitato alla diffusione ideologica e all’intrattenimento immediato, il sistema può prolungarsi amministrando la frustrazione senza risolverla.
Il mondo in cui viviamo non assomiglia alla distopia di Orwell in 1984. Somiglia sempre di più a quella di Huxley in Il mondo nuovo: segmentazione sociale statica, indottrinamento passivo mascherato da cultura pop, anestesia farmacologica, intrattenimento infinito come surrogato del senso. Non serve reprimere su larga scala quando si può distrarre in modo permanente. Non serve convincere quando basta intrattenere.
Ma anche queste mutazioni hanno un limite. Nessun sistema può mantenersi indefinitamente quando l’esperienza materiale della maggioranza si trasforma in una successione continua di perdite, precarietà ed esaurimento. La gestione digitale del malcontento può ritardare la rottura, ma non abolirla. Può attenuare il sintomo, ma non curare la malattia. Un ordine che affida la sua sopravvivenza a dissuasione, sorveglianza e precarizzazione può prolungare la sua agonia, ma non cambiarne il destino.
Educati all’immediatezza, al consumo come surrogato del desiderio e all’intrattenimento come anestesia, riusciamo a concepire solo due scenari: il collasso immediato o la sua impossibilità. Se non avviene ora, ci convinciamo che non avverrà mai. Ma la storia non funziona così. La maggior parte dei sistemi non collassa quando ci si aspetta che collassi; la storia umana si è dimostrata spiegabile, ma non prevedibile.
Qui si trova il paradosso finale. Il capitalismo automatizzato potrebbe non spezzarsi bruscamente. Può degradarsi lentamente, mutare, persistere come struttura diffusa e vuota. Ma se continua a ritenere che la precarizzazione totale della vita per la maggioranza sia gestibile con più dissuasione, più tecnologia e maggiore frammentazione sociale, finirà per imbattersi nello stesso limite storico di tutti i sistemi che portarono troppo lontano la propria logica interna. Può ritardare la rottura. Può camuffarla. Può anestetizzarla. Ma non può evitarla se sacrifica la base umana che lo sostiene.