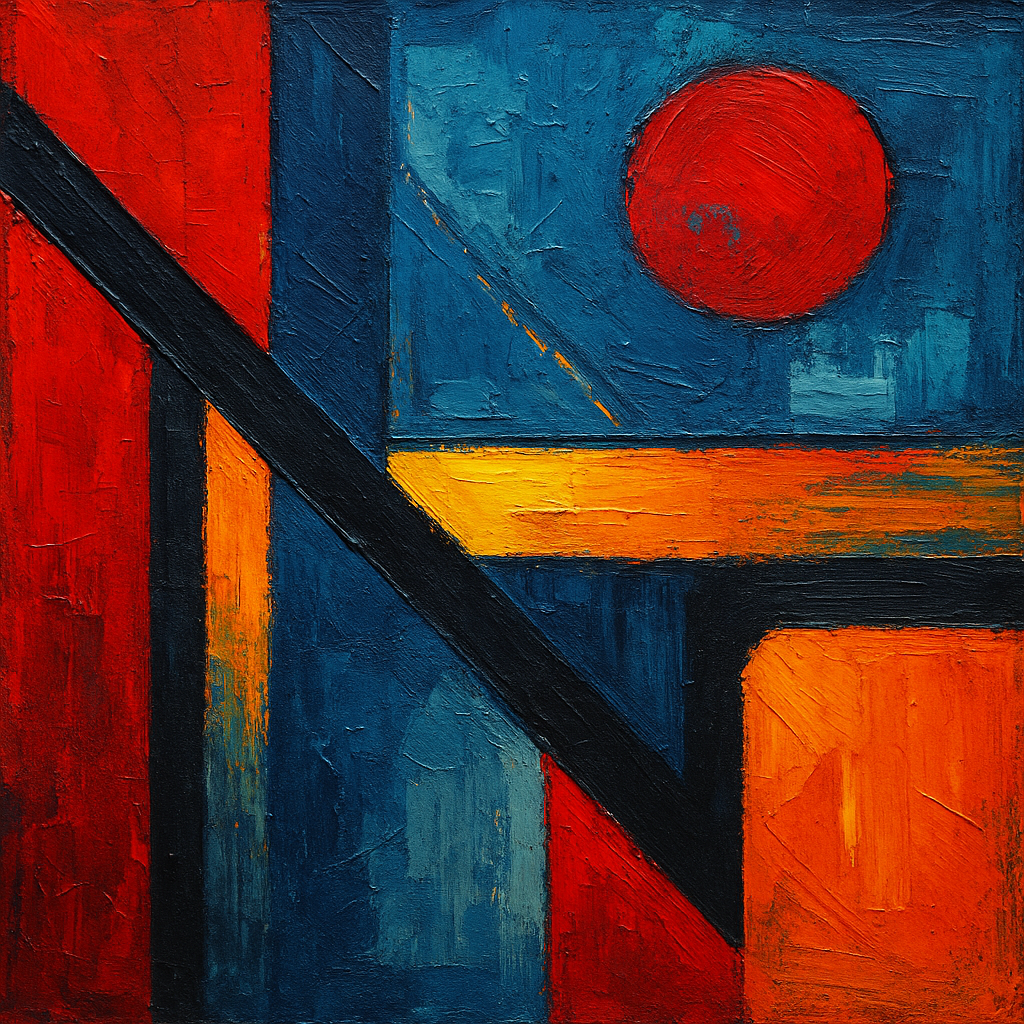
Perché i dazi alla Cina non significano lo stesso che i dazi all’Europa?
I dazi come simbolo di declino o riaffermazione geopolitica
Durante le prime decadi del XIX secolo, la Cina era la principale potenza dell’Asia orientale, con una struttura imperiale consolidata, un’economia agricola altamente produttiva e una cultura che si concepiva come il centro civilizzato del mondo. Il termine Zhōngguó (中国) —"Impero di Mezzo"— non era una semplice etichetta geografica, bensì un’affermazione politica e cosmologica: la Cina si vedeva come l’asse naturale dell’ordine, attorno al quale ruotavano civiltà minori, in una gerarchia tributaria che rifletteva sia la superiorità morale che la stabilità istituzionale del sistema dinastico.
Dal punto di vista economico, la Cina era una potenza manifatturiera preindustriale. La sua agricoltura, basata su tecniche intensive e sistemi di irrigazione ben sviluppati, garantiva una sicurezza alimentare costante. Su questa base fiorivano settori artigianali di altissima sofisticazione: seta, porcellana e tè non erano solo beni di lusso in Europa, ma anche simboli di una capacità tecnica che il continente ammirava senza riuscire a replicare. Il tè cinese, in particolare, divenne un’ossessione nazionale per l’Inghilterra a partire dal XVIII secolo, fino a rappresentare il 90% delle sue importazioni dalla Cina all’inizio del XIX secolo.
Il commercio con le potenze europee, tuttavia, era severamente limitato. Era consentito solo nel porto di Canton (Guangzhou) e sotto stretta supervisione statale. Inoltre, l’impero non mostrava interesse per i prodotti europei, considerati inferiori o irrilevanti per l’economia cinese. Poiché le autorità richiedevano che le transazioni avvenissero esclusivamente in argento, si generò uno squilibrio cronico nella bilancia commerciale: il Regno Unito —reduce dalla Rivoluzione Industriale— esportava grandi quantità di argento in Cina, ma non riusciva a vendere prodotti in proporzione. Questo flusso unidirezionale indeboliva le riserve monetarie britanniche e diventava un’anomalia strategica che l’impero, ormai in piena espansione globale, non era disposto a sostenere indefinitamente.
L’Impero britannico, tramite la Compagnia Britannica delle Indie Orientali, intraprese una strategia per invertire la bilancia commerciale sfavorevole. Coltivava oppio in India britannica e lo introduceva illegalmente in Cina attraverso commercianti privati appoggiati dalla diplomazia imperiale. Così, l’argento che prima fluiva verso la Cina cominciò a uscirne, e l’oppio passò da merce marginale a elemento strutturale nell’economia informale dell’impero.
Nel 1839, le esportazioni britanniche di oppio verso la Cina superavano le 1.400 tonnellate annue. La dipendenza si diffondeva in tutte le classi sociali. Lo Stato Qing, di fronte a una crisi sanitaria e morale, tentò di fermare l’ingresso dell’oppio. La risposta britannica fu la guerra. La Prima Guerra dell’Oppio (1839–1842) culminò con il Trattato di Nanchino, che impose l’apertura forzata dei porti, la legalizzazione dell’oppio, il pagamento di indennizzi e la cessione di Hong Kong. Seguirono altri trattati simili.
Le conseguenze furono devastanti. L’economia si disgregò, l’industria artigianale crollò e il tessuto sociale venne compromesso dall’espansione della dipendenza. Verso il 1880, le esportazioni britanniche di oppio superavano le 6.500 tonnellate annue. Si stima che circa il 27% della popolazione adulta maschile fosse dipendente dall’oppio alla fine del XIX secolo. La Cina, che era stata un centro di civiltà, si trasformò in un’economia controllata e un territorio frammentato. L’oppio non fu solo una merce: fu l’architettura silenziosa di una resa strutturale.
Il divieto effettivo dell’oppio arrivò solo con la consolidazione del potere del Partito Comunista Cinese nel 1949. Fu uno dei primi gesti simbolici del nuovo regime, segnando la chiusura del ciclo di sottomissione e l’inizio di un progetto di ricostruzione sovrana. Il Partito non si presentava solo come il vincitore di una guerra civile, ma come il soggetto politico che avrebbe posto fine a oltre un secolo di umiliazioni straniere.
Questo racconto si articolò attorno alla nozione di “secolo di umiliazione” (1839–1949), categoria storica ed emotiva che struttura la memoria collettiva moderna. Le Guerre dell’Oppio, i trattati ineguali, l’invasione giapponese e la perdita di territori vengono interpretati come una catena di spoliazioni di fronte a cui la fondazione della Repubblica Popolare non è solo una risposta politica, ma una riparazione esistenziale.
Questa narrazione è istituzionalizzata: viene insegnata nelle scuole, commemorata durante le festività nazionali, attraversa musei, libri di testo e i discorsi dello Stato. Si espande anche nella cultura popolare: film, serie, romanzi e videogiochi ricreano episodi di occupazione e resistenza. L’idea trasmessa è chiara: l’umiliazione non è stata la fine, ma l’origine di una nuova coscienza nazionale.
I dazi di Trump come specchio: dove l’Occidente perde senso, la Cina trova riaffermazione
Nel 2025, quando il governo di Donald Trump impone una nuova ondata di dazi, non solo contro la Cina ma anche contro storici alleati —come Germania, Giappone o Francia—, ciò che si incrina in Occidente non è solo un trattato commerciale, ma il racconto fondativo del capitalismo liberale, sostenuto dal dopoguerra su assiomi come il libero scambio, l’apertura dei mercati, la neutralità dell’economia rispetto alla politica e l’interdipendenza come principio di ordine globale.
L’uso del protezionismo come arma strategica contro gli alleati rompe la logica del beneficio reciproco ed espone una frattura tra i principi enunciati e l’esercizio reale del potere. Per l’Europa e altri storici partner degli USA, i dazi rappresentano più di una perdita economica: sono un colpo simbolico. Il garante dell’ordine liberale smette di garantirlo. Il mercato non si presenta più come uno spazio neutro: diventa un campo di battaglia.
Per la Cina, invece, quello stesso gesto ha valore di conferma. Il Partito Comunista non concepisce il mercato come un’entità autonoma, ma come uno strumento dello Stato. Dal 1949, il modello cinese combina pianificazione statale, protezione selettiva e apertura controllata. Le riforme non puntano a sottomettersi all’ordine globale, ma a integrarsi senza cedere il controllo sulle decisioni strategiche.
Il piano «Made in China 2025», avviato oltre un decennio fa per ridurre la dipendenza tecnologica e guidare settori chiave, ha già raggiunto più dell’86% dei suoi obiettivi, consolidando la Cina come leader mondiale in treni ad alta velocità, batterie, pannelli solari, robotica e veicoli elettrici. Le sanzioni non indeboliscono questa politica: la accelerano. Il decoupling non coglie di sorpresa la Cina: fa parte dell’ipotesi di base. Ciò che in Occidente è vissuto come crisi, in Cina si percepisce come validazione.
Il racconto cinese non si indebolisce di fronte al conflitto: si riafferma come espressione di una coerenza storica costante. Nel XIX secolo, una potenza straniera utilizzò il commercio per minare la sua sovranità; oggi, di fronte a nuove forme di pressione economica, la Cina non denuncia una rottura, ma riafferma i fondamenti che coltiva da oltre settant’anni. Fondamenti non solo strategici, ma anche storici, culturali e morali, che strutturano il suo progetto nazionale dal 1949. Mentre in Occidente i dazi aprono una frattura tra i principi fondativi del libero scambio e la pratica del potere, in Cina agiscono come conferma di una visione del mondo che non separa mai economia e politica, sovranità e sviluppo. In questa asimmetria di interpretazione non si confrontano solo due modelli; emergono anche due orizzonti distinti: tra chi sperimenta un punto di rottura e chi legge nel conflitto la conferma della propria continuità e ascesa.